categoria: Vicolo corto
Economia, perché ripensarla è ormai una necessità politica

L’autore di questo post è Gabriele Guzzi, laurea con lode in Economia alla Luiss e poi alla Bocconi. Ha lavorato per lavoce.info come fact-checker, è stato presidente di Rethinking Economics Bocconi e attualmente è dottorando presso l’Università Roma Tre –
Il 5 dicembre si è tenuto presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre l’evento “Perché ripensare l’Economia? – per una riforma dell’Università”, organizzato da Rethinking Economics Italia. Erano presenti, oltre al sottoscritto, Francesco Saraceno, Francesco Sylos Labini, Pasquale Tridico e il viceministro del Miur, Lorenzo Fioramonti.
Come è facile capire, la domanda che ha dato il titolo all’evento travalica le questione interne alle mura accademiche e ha a che fare con l’intero destino della nostra società. L’urgenza di ripensare l’economia infatti non è solo una rivendicazione di un sempre più largo gruppo di studenti e ricercatori in giro per il mondo, ma una vera e propria necessità politica, che riguarda tutti noi e determinerà le possibilità stesse della nostra civiltà di superare la crisi sociale, ambientale ed economica che stiamo attraversando.
Gravi disuguaglianze, una crescita ingiusta e stagnante, la precarietà che è diventata la cifra di un’intera generazione, emigrazioni di massa, un ambiente sull’orlo del collasso, i popoli in preda a una rivolta sociale. Questi sono solo alcuni dei sintomi che denotano una crisi di portata storica, che nei prossimi anni modificherà radicalmente il profilo delle nostre società, ma di cui l’economia mainstream, ossia quella insegnata e divulgata nelle maggiori università e dai principali mass media, non solo ignora le cause ma sembra anche aver contribuito ad esacerbare gli effetti.
Da questa prospettiva le istanze di cambiamento che sono interne ai dipartimenti di economia e quelle che si esprimono nel segreto dell’urna elettorale non appaiono più così lontane. L’insoddisfazione espressa da migliaia di studenti in giro per il mondo che si sono aggregati nel network Rethinking Economics e l’avanzata dei partiti anti-sistema, seppur nelle loro differenze, sembrano essere legati indissolubilmente alla stessa ondata storica di richiesta di cambiamento. In altre parole, vorrei argomentare, la nostra cultura dovrebbe iniziare a chiedersi con maggiore serietà se non siano i concetti diffusi e studiati nei dipartimenti di economia a costituire parte dei problemi che ci troviamo poi ad affrontare nella nostra quotidianità politica.
Ma procediamo con ordine. Cercherò qui di distinguere due filoni di critica, uno interno all’economia accademica e uno esterno. Entrambi ci serviranno per capire sia la situazione attuale dell’insegnamento universitario sia le radici epistemologiche e politiche che gli sono alla base, da cui quindi si può immaginare di impostare un eventuale ripensamento.

L’economista Hyman Minsky
Hyman Minsky, grande economista statunitense e teorico dell’instabilità finanziaria, già quaranta anni fa esprimeva grande diffidenza rispetto alle modalità ordinarie di insegnamento dell’economia. A suo avviso, e qui entriamo nel primo filone di analisi, i curricula accademici erano strutturalmente anti-intellettuali, costruiti cioè su una fondamentale carenza di pensiero.
La mancanza di corsi di storia del pensiero economico, secondo Minsky, impediva allo studente sia di avere una conoscenza teorica approfondita sia, e a maggior ragione, di maturare su di essa un’interpretazione critica, una sintesi problematica e viva sulle questioni economiche fondamentali. Nulla a che vedere quindi con una mera erudizione accademica. Al contrario Minsky riteneva che ciò invalidasse il nucleo essenziale delle teorie diffuse nelle università, e che questo indebolisse le capacità stesse degli economisti di comprendere e dirigere i sentieri di politica economica rilevanti.
In fondo lo stesso Keynes riteneva che nonostante gli economisti fossero la classe degli intellettuali più importanti dell’epoca, erano anche quelli meno competenti. E questa incompetenza non è certamente un fatto naturale e non deriva in chiave necessaria dal profilo generale dell’economista, ma è un effetto di una ristrettezza didattica che esclude ogni ragionamento storico ed emargina qualunque voce di dissenso.
Un altro punto essenziale da sottolineare è la preoccupante carenza di pluralismo teorico e metodologico all’interno dei curricula accademici. Come diretta conseguenza dell’assenza della storia del pensiero, l’economia mainstream viene oggi presentata nei caratteri di una scienza esatta, basata su leggi naturali, indipendenti dal contesto storico e istituzionale, tecnicamente strutturate e matematicamente deducibili. Più simile alla fisica che alla sociologia. Le nozioni economiche vengono insegnate come un blocco monolitico di conoscenze, fondate su una visione cumulativa della ricerca che procede unanimemente alla frontiera e che non ammette teorie differenti, e che non necessita perciò di alcuna analisi critica sulle assunzioni fondamentali.
I presupposti teorici circa il comportamento dell’uomo, la sua razionalità, le sue interazioni, le proprietà emergenti da tali relazioni, il funzionamento del lavoro, della moneta, e tutte le altre assunzioni critiche, come direbbe Milton Friedman, non vengono discussi e talvolta neanche onestamente esplicitati, sebbene influenzino radicalmente le conclusioni analitiche e le implicazioni politiche della teoria mainstream.
Naturalmente con questo non si vuole dire che all’economia manchino le metodologie per rendere esatta la sua analisi. Il problema emerge quando ad una particolare scuola di pensiero viene assicurata, per motivi extra-scientifici, una presunzione di esattezza maggiore delle altre teorie, sebbene queste ultime abbiano superato in maniera più efficace il processo di falsificazione empirica.
La mancanza di pluralismo si deduce quindi non solo dall’assenza nei curricula di filoni alternativi di pensiero ma anche dalla rigidità con cui la teoria tradizionale viene presentata. Il problema è che questa concezione epistemologica non solo è falsa ma ha anche pesanti ripercussioni sulle capacità esplicative dell’economia, ossia sulla comprensione dei fenomeni reali, che vengono spesso quindi mal compresi se non addirittura del tutto ignorati. Mi torna alla mente allora la frase di un mio professore di economia che diceva che la realtà è solo una delle teorie e neanche la più interessante.
E arriviamo ora al secondo filone di critica, quello che riguarda i rapporti esterni all’economia accademica. Per comprendere meglio il funzionamento della scienza economica dobbiamo infatti ricordarci, grazie alla grande lezione degli economisti classici, che l’economia è quella particolare disciplina che regola il conflitto tra interessi economici differenti. Utilizzando la metafora culinaria di una torta a fine pasto, possiamo dire che gli economisti sono quegli studiosi che devono stabilire le modalità migliori per suddividere la torta tra tutti gli invitati. Non c’è da scandalizzarsi nell’ipotizzare che ognuno cercherà di massimizzare la fetta di torta che spetta a lui e ai suoi cari, a scapito degli altri invitati. E che ognuno cercherà quindi di appoggiare la teoria di quello o quell’altro economista che lo legittimerà davanti a tutti gli altri a prendersi la fetta più grande.
È qui che capiamo il nesso indissolubile tra l’economia come disciplina e l’economia come conflitto tra interessi divergenti. L’economia politica, quindi, come direbbe Marx, è quella disciplina che regola questo conflitto attraverso un’interpretazione politica di questo conflitto. Nulla di tecnico, quindi, come sosterrebbe la teoria neoclassica, o naturalmente necessario.
Se comprendiamo tale aspetto, capiamo anche che la scienza economica e la politica economica si influenzano e si legittimano a vicenda in un circolo pericolosamente vizioso. Una politica economica infatti cercherà di supportare il filone teorico che meglio convaliderà le sue scelte distributive, come il filone teorico difenderà le ideologie politiche che seguiranno più pedissequamente i suoi suggerimenti.
Non appare quindi strano ad esempio che le politiche economiche di liberalizzazione, flessibilizzazione del lavoro e di tagli alla spesa pubblica siano avvenute proprio mentre prendeva piede, come dice il professor Francesco Saraceno nel suo libro “La scienza inutile”, l’emersione del monetarismo e del nuovo consenso macroeconomico e la sconfitta delle idee keynesiane. L’economia è quindi più che una scienza sociale una scienza politica, che dipende strettamente dai rapporti di forza e di potere interni alla società.
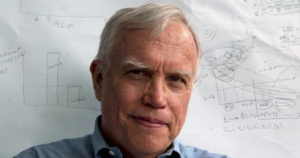
Il professor James Heckman
Sarebbe inoltre ingenuo nel 2018 ritenere che il ripensamento dell’economia passi esclusivamente attraverso una lotta tra keynesiani e neoclassici. Come ha detto giustamente il viceministro Lorenzo Fioramonti, nuove urgenze sono entrate nella nostra quotidianità politica. Il dramma ambientale ad esempio mette a dura prova i modelli di crescita tradizionale, nei quali l’esaurimento delle risorse naturali e l’inquinamento dell’atmosfera non vengono trattati se non marginalmente e sempre con metodi insufficienti. L’economista vede infatti con cattivo occhio le tematiche ecologiche, ritenendole secondarie o comunque poco rilevanti. Tuttavia i dati che stanno emergendo in questi ultimi anni, ad esempio sull’aumento medio delle temperature, richiedono un’attenzione massima e un’integrazione sempre maggiore tra le giuste esigenze di occupazione e di mantenimento dei diritti sociali con la rivoluzione tecnica e politica necessaria ad affrontare il dramma ambientale che metterà a rischio la sopravvivenza stessa della razza umana sulla Terra.
Ecco allora che la scienza economica e il destino delle nostre società non sembrano più campi così indipendenti. Al contrario, la disciplina economica richiede a mio avviso un ripensamento globale e molto profondo. Che sappia aprirsi alla ricchezza di altre scuole di pensiero e le sappia integrare con le nuove esigenze della contemporaneità, e che sappia quindi riformulare molto di ciò che oggi viene dato per scontato nelle università, compresi i criteri di valutazione della ricerca. Non bisogna dimenticarsi infatti che i metodi con cui vengono valutati i ricercatori e stabiliti gli avanzamenti di carriera, come dice il premio Nobel James Heckman, hanno la piccola controindicazione di omologare il pensiero alle teorie mainstream e di asfissiare la libertà intellettuale degli economisti.
Twitter @GabrieleGuzzi
