categoria: Res Publica
La politica italiana ha deciso di impadronirsi del mercato
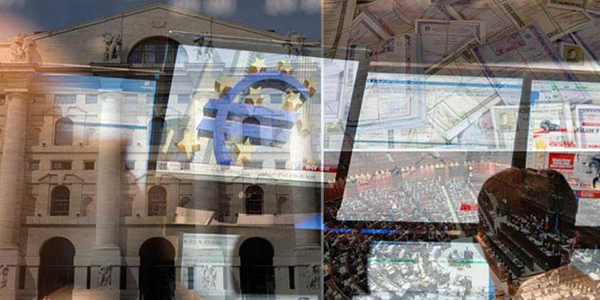
Co-autore di questo post è Beniamino Piccone
L’Economist ha scomodato persino l’amato Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa per condire un pezzo molto amaro sul declino del capitalismo italiano. In realtà, sempre rimanendo in tema di letteratura siciliana, sarebbe stato forse più appropriato citare romanzi borghesi, come quelli di Giovanni Verga o di Stefania Auci (che ha raccontato l’epopea dei Florio, i Buddenbrook nostrani), piuttosto che un romanzo aristocratico. Ma l’accostamento resta comunque affascinante.
L’articolo, dopo aver enunciato qualche numero (solo 7 aziende italiane quotate rientrano nelle top 1000 mondiali in termini di capitalizzazione) e la fuga all’estero di tanti nostri national champions, si concentra poi su quali sarebbero, a detta dell’autore, le tre cause del declino.
La prima riguarda la mancanza di capitale finanziario, contraddistinta da un eccessivo ricorso al finanziamento tramite short-term debts, erogazione dei prestiti sulla base dello storico e non sulla qualità innovativa dell’idea, assenza di un mercato di venture capital. L’assetto del nostro sistema finanziario, incentrato sugli intermediari creditizi, è il punto critico decisivo. Infatti il corso degli eventi sta dimostrando che il secolo schumpeteriano che stiamo vivendo – nel quale la distruzione creativa avanza con accelerazioni tremende, dove intere industrie (vi ricordate i dischi in vinile o i cd?) o imprese scompaiono in un batter d’occhio (vi ricordate della Nokia, leader nei telefonini?) – impone alle imprese una dimensione tale che solo i mercati finanziari sono in grado di sostenere (tramite fusioni e acquisizioni).
Il sistema bancocentrico, il classico europeo, non è adeguato ai tempi vorticosi di oggi. Prima che una banca capisca che un settore entrerà in crisi, passa tempo immemorabile per cui, poi è difficile tagliare il ramo su cui è seduto (il credito come si fa a ridurre in tempi di crisi strutturale?).
I mercati finanziari, tanto odiati in questo Paese, sono fondamentali per la crescita. Dobbiamo uscire dalla logica per cui l’economia reale è una cosa e l’economia finanziaria un’altra. Sono legate! A doppio filo. Senza un sistema finanziario mercatocentrico, manca il sangue alle imprese innovative e si continuano a finanziare le imprese perdenti. Gli italiani, eccellenti risparmiatori, hanno una bassa propensione al rischio (vediamo come i depositi bancari si ingolfino ogni mese di più) ed una particolare diffidenza dal farlo in favore di grandi imprese (dalle performance ampiamente deludenti) o controllate dallo Stato.
La seconda causa concerne la mancanza di capitale sociale, sebbene gli esempi citati esulino un po’ dalla nozione accademica del termine. Si menziona un sondaggio secondo cui 9 italiani su 10 vorrebbero un tetto agli stipendi dei manager, il dato più alto nel mondo occidentale. Per far prevalere la cultura civica sul familismo amorale è necessario che il cittadino si faccia parte attiva, prenda contezza della vita pubblica, si informi e diventi quindi parte di una cittadinanza attiva. Non è facile per un popolo abituato da secoli a servire. Lo scrittore Cesare Garboli parlava di una “vocazione servile”, avendo noi “servito tutti i popoli della terra: greci, bizantini, barbari, francesi, spagnoli, inglesi, austriaci, persino russi e infine i piemontesi”. (Ricordi tristi e civili, Einaudi, 2001, cit.).
Poi l’autore menziona alcune difficoltà strutturali, come le scarse performance in alcuni indicatori della classifica doing business della World Bank (in termini di enforcement dei contratti, tassazione, rilascio di permessi pubblici). Con vena politica, l’articolo evidenzia altresì come i soldi dei contribuenti vengano spesso utilizzati per salvare imprese da perenni fallimenti (citando l’immancabile Alitalia) anziché per migliorare le infrastrutture.
La mancanza di capitale umano è la terza causa. Si menziona l’età media eccessivamente alta dei capi-azienda (Berlusconi, Del Vecchio, Armani), denunciando un problema tipico del nostro capitalismo, quello del passaggio generazionale. Un contesto che taglia fuori i giovani, che spesso scelgono la via estera, foriera di maggiori opportunità.
L’analisi appare condivisibile per alcuni aspetti e trova buoni riscontri nella storiografia economica, pur non esaurendo ovviamente tutte le altre concause. Come noto, il capitalismo novecentesco italiano è cresciuto attorno ad alcune grandi famiglie (Agnelli, Falck, Pirelli ecc.) ed al ruolo attivo dello Stato nell’economia, sia durante il fascismo sia dopo. A seguito della crisi degli anni ’70, le due componenti hanno iniziato il loro declino, con la seguente stagione di crisi industriali e di privatizzazioni, compensata solo in parte dalla crescita delle piccole e medie imprese della “terza via” (Nord-est e Adriatico). L’entrata nell’euro, i cui vantaggi non sono stati sfruttati per aumentare la produttività del nostro sistema, ha fatto emergere le nostre lacune competitive, portando però alla luce anche diverse eccellenze che hanno saputo ben inserirsi nelle catene globali del valore.
Sebbene in questa fase tutta l’economia sembri in bambola a causa della pandemia, con l’incertezza a far da padrone, possiamo in ogni caso ben intravedere come la politica italiana stia tentando di invertire la rotta di declino imboccata dal nostro capitalismo. Anziché affrontare di petto le cause elencate dall’ Economist e le altre definite “strutturali”, la maggioranza politica attuale (ma anche buona parte delle opposizioni) sembra intenzionata a riproporre lo schema dello Stato imprenditore o comunque soggetto attivo nell’economia. Si tratta di intenzioni precedenti all’era Covid (come descritto in tale pezzo), che non sono rimaste sulla carta visto il dinamismo della Cassa Depositi e Prestiti. Quest’ultima infatti è intervenuta, tra le altre cose, sui dossier Atlantia e Borsa Italiana, nella creazione del colosso Webuild e nelle nozze tra Nexi e Sia.
Sembrano tornare alla mente argomenti chiave del dibattito politico-economico italiano del ‘900, come gli scambi di vedute fra Pasquale Saraceno e Donato Menichella (per il quale erano necessarie “mani sapienti e coscienze rette”, dove sono finite?). Quel che qui conta è ricordare come l’intervento pubblico nell’economia abbia contribuito al miracolo economico post-guerra, soprattutto nella fase in cui l’IRI godeva di autonomia dalla politica. Dopodiché, principalmente dalla creazione del Ministero delle partecipazioni statali in poi, le logiche politiche hanno schiacciato la via dell’efficienza, fino alla crisi ed alla implosione del modello.
Nello scenario attuale, molte cose sono cambiate. Ma complice la sospensione temporanea della disciplina europea sugli aiuti di Stato, disposta a causa della pandemia, l’intervento pubblico è stato completamente sdoganato ed ha ambizioni molto grandi. Ma il tutto non si restringe ai cosiddetti settori chiave e strategici per il Paese (una definizione che si allarga sempre più), poiché già in epoca pre-Covid, l’Ad di CDP, rispondendo alle domande del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, dichiarava che «In tre anni Cdp diventerà partner strategico di 60mila Pmi.» Recentemente, in un’altra intervista, concessa al medesimo Direttore, confidava che «Il nostro obiettivo è quello di costruire campioni nazionali». I campioni nazionali non li decide ex- ante lo Stato, ma il mercato, ex-post. Più che una “politica industriale”, ci vorrebbe una “politica per l’industria”.
Se questa è la strada (avallata, con altri toni, anche dal Presidente del Consiglio), significa che intendiamo abdicare alla possibilità di creare nuove grandi imprese private, perché laddove la mano dello Stato è particolarmente visibile, la mano invisibile del mercato fa più fatica a sprigionare i suoi benevoli effetti. E, quindi, rischiamo di illuderci nuovamente e di assopirci su quel “compromesso senza riforme” (Fabrizio Barca, “Storia del Capitalismo italiano”, Donzelli) con il quale non vogliamo fare i conti da troppi decenni. Si obietterà che il nostro è un capitalismo diverso da quello anglo-sassone, che anche nazioni come Francia (soprattutto) e Germania intervengano spesso nell’economia, ma si dimentica di considerare gli effetti a lungo termine di queste scelte. Nulla si vede in prospettiva, ad esempio, per affrontare le cause del declino identificate dall’Economist o le altre notoriamente strutturali. Siamo tornati alla visione dello Stato panacea, che controlla gli equilibri sociali ed occupazionali con i soldi del contribuente (siccome i contribuenti sono circa il 50%, si capisce perché sono in pochi a protestare per gli investimenti “a capocchia” di Stato).
Funzionerà? Questa volta i manager pubblici guideranno l’innovazione e preserveranno l’efficienza? Noi siamo molto scettici, perché senza mercati finanziari, l’impresa non può competere con i colossi mondiali (Ant Group raccoglie in IPO 34,5 miliardi di dollari, qualche impresa europea potrà competere con costoro?).
Twitter @beniapiccone – @frabruno88
